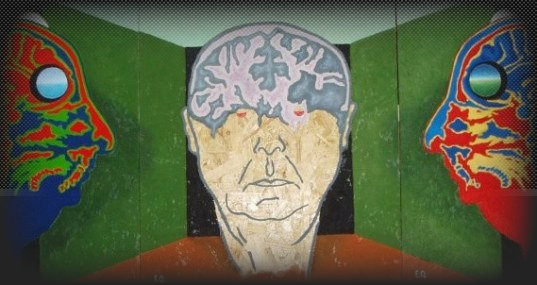



|
|
UN PITTORE VERO Francesco Mastronardi
Il pittore racconta di sé con i propri quadri. Con una narrazione a colpi di pennello. A rendere esclusiva l’autobiografia pittorica di Enrico Quattrocchi concorrono due aspetti originali. Alla lunga parentesi compresa tra gli studi artistici e il periodo più fecondo si accompagna l’intensità di un linguaggio intriso di solitudine. Tra «il prima» del Corso presso la Scuola di San Giacomo a Roma, cui lo aveva portato una precoce vocazione, e «il poi» dell’esplosione pittorica degli anni più recenti, espressasi con una moltitudine di appassionati lavori, si è avuta una pluridecennale traversata di un deserto fertile. Un deserto perché privo dell’irrigazione artistica. Fertile perché ricco di sentimenti vissuti e di un’operosità professionale spesa nel tentativo di smentire, per quanto è possibile, la maliziosa e paradossale opinione di chi ritiene che far funzionare una banca sia «più criminale» del rapinarla. Quanto alla solitudine che traspare dalle tele di Enrico, essa non è isolamento ma concentrazione. Non è rinuncia ma ricerca. Non è abbandono all’illusione e tanto meno alla disperazione ma esplorazione di sé e degli altri. Nella sua muta conversazione con la superficie da dipingere, condotta nel più complice degli ambienti, il pittore non si fa mai isola. Si svela invece, per le composizioni cui dà vita e le reazioni che suscita, come una penisola circondata da un mare di positive tentazioni artistiche e saldamente ancorata al continente della famiglia, dei valori, delle responsabilità. A ben guardare c’è una connessione stringente tra la parentesi professionale e la qualità acquisita dal linguaggio. È come se nel lungo percorso all’interno del mondo della finanza Enrico venisse accumulando tele dentro di sé lasciando sedimentare nel silos della memoria esperienze, impressioni, immagini, perfino voci e silenzi. La maturazione dello stile pittorico avveniva in incognito, senza rendersi visibile ma pronta ad essere messa alla prova. L’ «apriti Sesamo» si fa sentire in modo sommesso ma persuasivo nello spazio di libertà introdotto dall’esaurirsi dell’attività bancaria. Una dopo l’altra le tele virtuali escono dalla preziosa caverna dei tesori e prendono luce, colori, forme. È il giorno dopo gli anni verdi e, come allora, si torna a dipingere dall’alba fino a far «coricare il sole». Con gli anni 2000 si riannoda il filo dell’autobiografia artistica. Tornano a coincidere quello che si è e quello che si può essere. Non vi è però nessuna negazione del passato, ché anzi è proprio il rigore della vita quotidiana, vissuta con serietà sul lavoro e nella famiglia, nella pluralità spesso ripetitiva di comportamenti, gesti e parole, a dare sostanza alla dimensione, e quindi alla grandezza, del ritrovato pittore. Quella dell’artista è d’altronde sempre un’identità multipla e pretende capacità di ascolto e abitudine anche alle azioni più umili per riuscire a dire qualcosa di nuovo. A testimoniare che per Enrico il passato non è mai un archivio per il deposito dei ricordi ma una realtà sempre vitale inserita nella continuità del tempo vi sono tutte le sue tele e forse alcune più delle altre. Mi piace ricordare, fra le tante, il ciclo dei vizi capitali, le ricorrenti rappresentazioni delle camicie, la sorprendente serie degli spaventapasseri. Nella raffigurazione delle diverse pratiche del male, cui fanno da contrappunto devoti omaggi ad alcuni tra i più grandi pittori di ogni epoca, c’è lo sguardo, privo di moralismo, di chi ne ha viste tante nella vita e, pur essendo stato sfiorato da alcuni di quei vizi, si è adoperato per tenersene lontano sapendo che il proprio passaggio terreno è troppo breve per permettersi il lusso di attraversarlo male. Il tema delle camicie incravattate, pur nella divertita varietà dei colori, non può non richiamare lo status omologante dei colletti bianchi. Dietro il convenzionale indumento della camicia e stretti nel cappio volontario della cravatta, sembra suggerire il pittore, non vi sono dei moderni e burocratici «cavalieri croati», alle prese con immaginari nemici, ma persone in carne ed ossa, ciascuna diversa dalle altre e tutte potenzialmente sincere e solidali. Gli spaventapasseri, da ultimo, sono soltanto dei fantocci issati su fragili pertiche per mostrarsi più alti e minacciosi. Nella realtà, sembra essere in questo caso il messaggio del pittore, non solo non bisogna lasciarsene spaventare, ma vanno riconosciuti nella loro vera natura. Sono gli umani più sprovveduti perché legati all’apparire e non all’essere e destinati quindi all’infelicità. Sono tutti fortemente radicati nella vita concreta i lavori di Enrico. Nella sua rinnovata navigazione pittorica la meta perseguita non è mai il non-luogo dell’utopia e neppure luoghi improbabili e misteriosi. Il viaggio affrontato di volta in volta, facendo leva su una robusta combinazione mani-cuore-cervello e mettendo all’opera la bussola della saggezza, non è per andare altrove ma per venire dove già si è. Per svelare a se stesso come ci si è arrivati. Un viaggio e poi un altro e altri ancora, nella suggestione di composizioni che si formano e si propongono ricche di creatività e di tecnica, suggeriscono una riflessione, esigono una reazione, si dissolvono non prive di echi per cedere la scena a quelle successive. Ogni volta, nella sequenza di avventurosi viaggi intrapresi dal pittore, per capire meglio, saperne di più, tentare risposte credibili e porsi nuove domande. Per rendere infine esplicite vicende e sensazioni dimenticate o non colte. Per dare voce a parole mai dette e sostanza a cose non fatte. Per dispiegare con recuperata lentezza e sapiente maestria quel filo che la sua Arianna di turno gli aveva affidato e che, facendosi luminoso e policromico sotto la cadenzata pressione del pennello, gli rende più sicuro e coinvolgente il labirintico percorso quotidiano. Se sono i quadri a fare il pittore, piuttosto che il contrario, i suoi quadri fanno di Enrico Quattrocchi un pittore vero. |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Site Map |